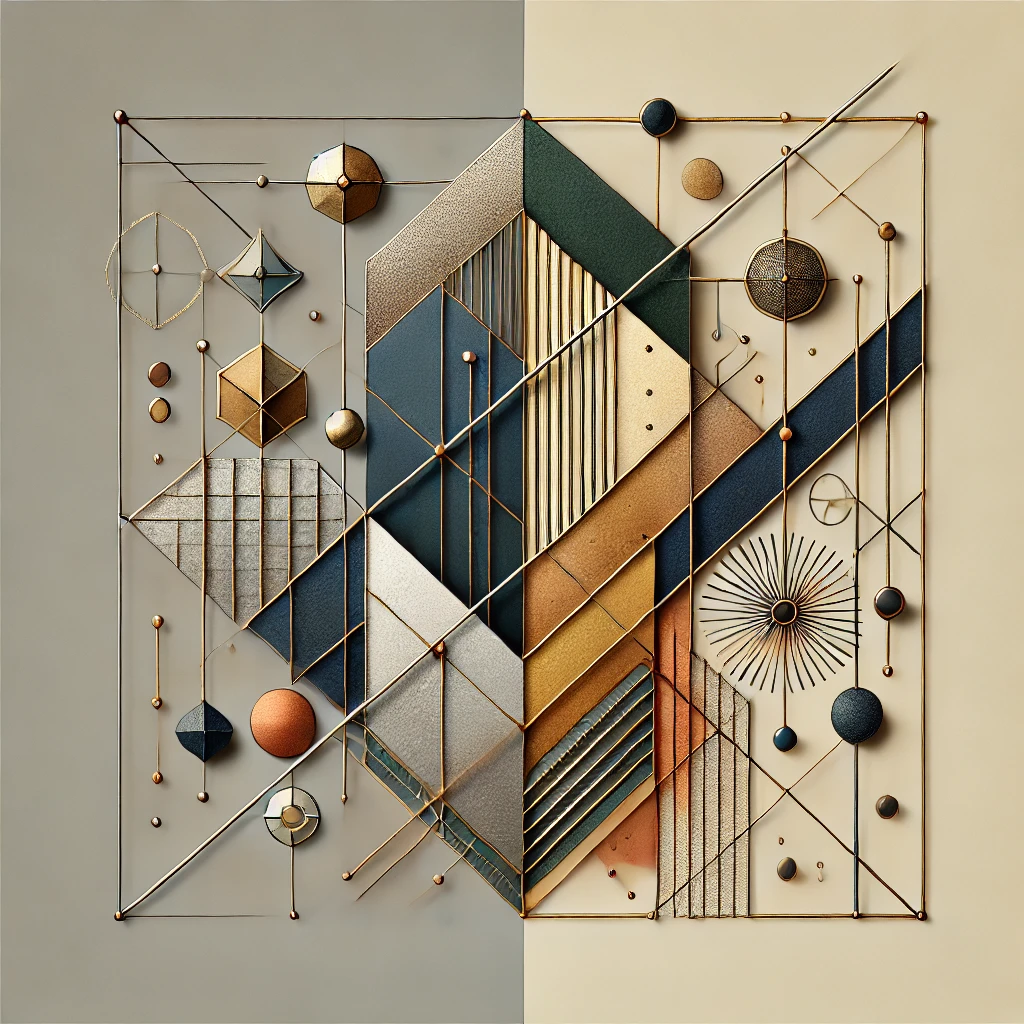
Assistiamo a rapidi progressi tecnologici, nuovi prodotti eleganti, processi migliorati e aggiornamenti costanti, ma in molti casi questi progressi non riescono ad avere un impatto significativo dove è più necessario. Troppo spesso ciò è dovuto al fatto che non vengono valutati utilizzando quadri di riferimento in grado di coglierne il vero valore e la rilevanza.
Questa critica vale anche per i manuali di Oslo e Frascati, due testi di riferimento elaborati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per guidare la misurazione delle attività di innovazione e ricerca e sviluppo. Questi manuali definiscono le definizioni, gli indicatori e i criteri per determinare cosa si intende per innovazione e sono ampiamente utilizzati per raccogliere, analizzare e confrontare i dati sull'innovazione a livello globale. Tuttavia, i loro limiti sono diventati sempre più evidenti, in particolare quando vengono applicati al Sud del mondo, dove l'innovazione assume spesso forme che sfuggono alle definizioni convenzionali.
Ciò solleva questioni fondamentali quali: “Come si misura l'innovazione nel Sud del mondo, ammesso che sia possibile? Le innovazioni frugali, informali e inverse, comuni nei contesti in via di sviluppo, rientrano nelle definizioni dell'OCSE? I manuali di Oslo e Frascati tengono adeguatamente conto della sostenibilità e degli SDG? E se no, quali quadri alternativi esistono?”
Per quanto riguarda la sostenibilità e gli SDG, i manuali di Oslo e Frascati sono stati entrambi sviluppati molto prima degli SDG (2015) e, sebbene siano stati periodicamente rivisti (da ultimo rispettivamente nel 2015 e nel 2018), il loro focus principale rimane sugli indicatori economici e tecnologici dell'innovazione e della R&S, con un'enfasi esplicita limitata sulla sostenibilità sociale e ambientale. Ad esempio, il Manuale di Frascati (2015) definisce ancora la R&S in modo restrittivo, concentrandosi sul lavoro sistematico, formale e creativo volto ad aumentare il patrimonio di conoscenze, non necessariamente per raggiungere obiettivi sociali o ambientali[1].
Il Manuale di Oslo (2018, 4a ed.) adotta una visione più ampia includendo le innovazioni organizzative e di marketing e riconosce che le innovazioni possono contribuire indirettamente agli obiettivi sociali. Tuttavia, non allinea direttamente i suoi indicatori agli SDG, né affronta esplicitamente le innovazioni frugali o di base[2]. Gli studiosi hanno criticato questo disallineamento tra ciò che misuriamo e ciò di cui il mondo ha effettivamente bisogno per raggiungere la sostenibilità[3].
Nella misurazione pratica dell'innovazione nel Sud del mondo, in particolare delle innovazioni frugali, delle innovazioni inverse e della creatività del settore informale, queste non rientrano nell'ambito di ciò che i manuali dell'OCSE definiscono innovazione. Queste innovazioni sono spesso sviluppate in contesti con risorse limitate, sfruttando in modo creativo gli strumenti e le conoscenze esistenti senza processi formali di ricerca e sviluppo o documentazione.
Il Manuale di Bogotá[4], sviluppato per l'America Latina, affronta alcune di queste differenze contestuali e considera esplicitamente il settore informale e l'innovazione sociale. Tuttavia, rimane meno conosciuto e utilizzato rispetto ai manuali dell'OCSE. La ricerca ha dimostrato che le economie in via di sviluppo sono altamente innovative in modi che non vengono rilevati dalle indagini standard. Ad esempio, Chandy & Prabhu (2012) evidenziano come l'innovazione frugale in India e in Africa crei soluzioni accessibili e scalabili a bisogni sociali urgenti, ma tali contributi raramente vengono registrati nelle statistiche ufficiali sull'innovazione[5].
Per capire se le innovazioni frugali e informali si adattano ai quadri dell'OCSE, direi di no, non bene. In primo luogo, i manuali dell'OCSE presuppongono alcune caratteristiche dell'innovazione: novità, creatività, incertezza, processi sistematici e trasferibilità/riproducibilità.
In secondo luogo, le innovazioni frugali e informali spesso avvengono al di fuori della ricerca e sviluppo formale o dei contesti aziendali e quindi non soddisfano questi criteri nonostante la loro rilevanza e il loro impatto sulla sostenibilità e lo sviluppo. Ad esempio, una pompa ad energia solare progettata localmente da una cooperativa nelle zone rurali del Kenya può migliorare profondamente la vita delle persone, ma non sarebbe considerata un'innovazione secondo le definizioni dell'OCSE se non fosse documentata da attività di ricerca e sviluppo o dalla sua introduzione sul mercato.
Inoltre, il fatto che la sostenibilità sia in fase di declino o di rinascita dipende dal punto di vista. I manuali forniscono quadri coerenti per monitorare l'innovazione nelle economie avanzate, il che è prezioso per le politiche comparative e gli investimenti. Tuttavia, i loro limiti rischiano di emarginare i tipi di innovazione più importanti per il raggiungimento della sostenibilità nelle regioni in via di sviluppo. Lungi dall'essere neutrale, il modo in cui misuriamo l'innovazione determina quali innovazioni vengono viste, sostenute e diffuse e quali vengono ignorate. Per rilanciare veramente la sostenibilità, abbiamo bisogno di quadri di misurazione che includano diverse forme di innovazione, in particolare quelle che danno priorità ai risultati sociali e ambientali rispetto ai guadagni commerciali.
La mia ricerca in corso interroga questi punti ciechi, non limitandosi a identificarli, ma esplorando anche le loro implicazioni radicate nei contesti del Sud. Sebbene gli ecosistemi di innovazione nel Sud del mondo siano ricchi e dinamici, le metriche esistenti non riescono a coglierne la complessità. Anziché affidarsi esclusivamente a modelli eurocentrici, è possibile ripensare la misurazione dell'innovazione, ad esempio adattando strumenti radicati a livello regionale come il Manuale di Bogotá o sviluppando nuove metodologie che riflettano le realtà locali e siano in linea con gli imperativi globali di sostenibilità.
Benedicta Quarcoo
[1] OCSE (2015), Manuale di Frascati 2015: Linee guida per la raccolta e la comunicazione dei dati sulla ricerca e lo sviluppo sperimentale, La misurazione delle attività scientifiche, tecnologiche e di innovazione, Pubblicazioni OCSE, Parigi, https://doi.org/10.1787/9789264239012-en.
[2] OCSE/Eurostat (2018), Manuale di Oslo 2018: Linee guida per la raccolta, la comunicazione e l'utilizzo dei dati sull'innovazione, 4a edizione, Misurazione delle attività scientifiche, tecnologiche e di innovazione, Pubblicazioni OCSE, Parigi, https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
[3] Godin, B., & Vinck, D. (2017). “Introduction: innovation – from the forbidden to a cliché”. In Critical Studies of Innovation. Cheltenham, Regno Unito: Edward Elgar Publishing. Estratto il 23 luglio 2025 da https://doi.org/10.4337/9781785367229.00007
[4] Manuale di Bogotà (2001), Standardizzazione degli indicatori di innovazione tecnologica nei paesi dell'America Latina e dei Caraibi
[5] Tellis, GJ., Chandy, R., & Prabhu, J. (2012). Domande chiave sull'innovazione nel contesto B2B. In G. Lilien, & R. Grewal (Eds.), Manuale di marketing business to business (pp. 582-595). Edward Elgar Publishing.